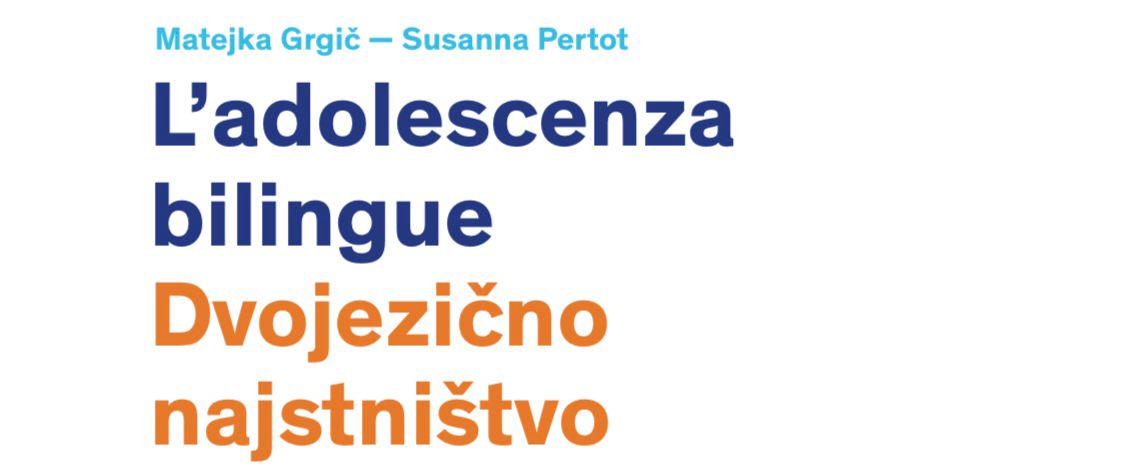
Si tratta di un manuale bilingue, una continuazione di un opuscolo simile circa l’infanzia bilingue, che vuole essere uno strumento nuovo per offrire “spunti di riflessione per genitori, insegnanti, educatori, istruttori di preadolescenti tra i 10 e i 13 anni”. Questo libro di testo è stato creato in riferimento alla minoranza slovena in Italia, però, come spiegato dalle autrici che da anni si occupano di ricerca nel campo del bilinguismo, sono molte le similitudini con il nostro territorio bilingue; infatti, il manuale da loro creato può essere una guida per genitori che crescono i propri figli nel plurilinguismo, e per i docenti che insegnano ad adolescenti plurilingui.
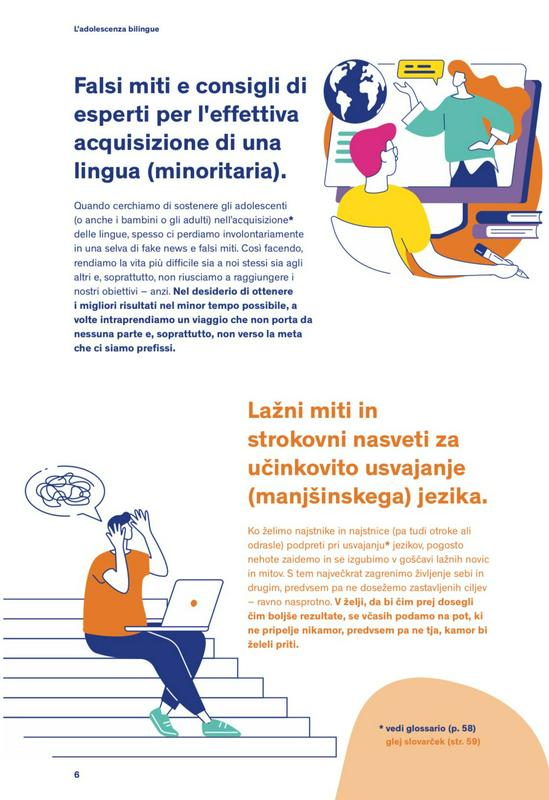
Abbiamo parlato con Susanna Pertot, psicologa e psicoterapeuta, per sapere com’è nata la necessità di scrivere questo manuale e a chi è dedicato.
“Quanto riguarda l'adolescenza di materiale ce n’è poco, dunque questo opuscolo è un po’ una sfida che abbiamo colto la collega Matejka Grgič ed io, per offrire sia agli insegnanti, ma soprattutto ai genitori, degli spunti anche di riflessione sull’adolescenza in un ambiente bilingue. Che cosa si può fare, ovvero come si può aiutare i ragazzi a mantenere due lingue e a svilupparsi come dei bilingui competenti.”
La linguista Matejka Grgič nell’opuscolo si è occupata dei cosiddetti “falsi miti” sulla lingua.
“Ce ne sono una marea, vengono anche considerati da un punto di vista scientifico nuclei ideologici, perché si tratta di ideologie studiate dall’antropologia, dalla sociologia, che vengono trasmesse poi alla lingua. Una di queste è per esempio il mito della madrelingua, cioè la madre che trasmette la lingua e le conoscenze linguistiche ai figli. E poi questa lingua, un po’ come l'amore nei confronti della madre, permane per tutta la vita. In realtà è un mito a 360°, nel senso che i bambini imparano la lingua con tutte le persone con le quali vengono a contatto durante la loro vita, quindi non solo la madre, ma anche il padre, i nonni, i vicini di casa, gli amici, parenti, insomma chi più ne ha più ne metta. Tutti questi costituiscono i loro informatori linguistici.”
B.Ž.



































































